
Forse abbiamo finalmente capito Andrew Luck
Negli ultimi giorni, grazie a un magnifico podcast a episodi di Zak Keefer di The Athletic, il nome di Andrew Luck è tornato prepotentemente d’attualità nell’universo NFL: come del resto inevitabile se si parla di Luck, la risposta emotiva è stata tanto forte quanto variegata.
C’è chi ha provato nostalgia – anche se probabilmente nemmeno Max Pezzali riuscirebbe a essere nostalgico di qualcosa occorso nemmeno tre anni fa -, chi rispettabile dolore esacerbato da ben ragionati what if, chi vera e propria pace dei sensi constatando quanto il ragazzo meriti ogni centilitro della serenità che sta scandendo la sua nuova vita, una vita finalmente libera da quel costante dolore fisico che lo ha costretto ad annunciare il ritiro dal football giocato a 29 miseri anni.
Le ripercussioni della sua sorprendente, e in un certo senso devastante, uscita di scena le percepiamo tutt’oggi, basti chiedere agli Indianapolis Colts od osservare quanti individui abbiano seguito il suo esempio appendendo casco e armatura al chiodo a età sempre più precoci, anche se un lettore accorto potrebbe mettere in risalto che un Borland qualsiasi si sia ritirato dopo un solo anno fra i professionisti in tempi non sospetti – ossia con Luck ancora in un roster NFL.
L’intera città di Indianapolis e i Colts devono ancora riprendersi del tutto da quel maledetto 24 agosto 2019, giorno che a più riprese ho identificato come entità metafisica che ha di fatto creato un “prima” e un “dopo” non solo nella capitale dell’Indiana ma in tutta la National Football League.
In un certo senso, l’incredibile lavoro di Zak Keefer – vi consiglio, vi caldeggio e vi imploro di farvi il favore di ascoltare questo podcast, è semplicemente magnifico – non ha solamente raccontato nel migliore dei modi una della storie più interessanti del ventunesimo secolo sportivo, ma ha chiuso un cerchio fornendoci la conclusione che più desideravamo a una vicenda che molti di noi devono ancora realmente finire di metabolizzare.
Andrew Luck, al momento, è un padre di famiglia che si sta godendo la vita fra viaggi, libri e per l’appunto famiglia: niente apparizioni in tivù, niente cacofonia sui social network, niente comparsate in film o serie TV, niente di niente, Luck da tre anni a questa parte si sta godendo l’inverosimile anonimato dal quale noi tutti proviamo faticosamente a emergere assaporando ogni singolo istante della normalità di una vita che, a un certo punto, sembrava destinata a essere compromessa.
Just an appreciation post for Andrew Luck.
– Most wins for a QB drafted 1st overall in his first year (11)
– 4X Pro Bowl
– Number 2 in passing TD’s thru first 6 seasons (171)
– 4X 4,000 passing yards
– #Colts leader in most passing yards in one single season (4,761) pic.twitter.com/lYnAdqzGVc
— Colts Coverage (@Colts_Coverage) July 11, 2022
Normalità, per l’appunto.
In questa polisemica parola intercettiamo una delle principali ragioni per le quali Andrew Luck ha detto basta: anni di massacro legalizzato da parte di una trentina di pass rush stavano per condannarlo a un’esistenza irrimediabilmente scandita da dolore, fisioterapia continua e, di nuovo, dolore.
Un apparentemente banale – per i canoni NFL – infortunio alla spalla rimediato nel 2015 ha di fatto stravolto tre interminabili anni della sua vita, condannandolo a un loop infinito di dolore, frustrazione e fisioterapia: il tifoso cinico potrebbe affermare che per un contratto da 140 milioni di dollari in sei anni sarebbe più che disposto a convivere con un braccio funzionante solamente per una manciata di domeniche che, per il resto dell’anno, ha bisogno di dolorosissime cure per adempiere ai doveri di braccio.
Sono punti di vista.
Ciò che il podcast ha tuttavia messo in evidenza con maggior insistenza – e brillantezza – è l’unicità di Andrew Austen Luck l’essere umano, persona che veramente non ha eguali nella ricca e variegata storia della National Football League.
In un solo corpo Andrew Luck coniugava l’animo di un nerd che leggeva di propria spontanea iniziativa libri sul cemento – sì, libri sul CEMENTO – a lo stereotipo del jock che sentiva il bisogno fisiologico di essere colpito duramente da avversari perché, nella sua testa, il contatto era l’essenza del football americano e sperimentarlo in prima persona era per lui fondamentale per vivere la propria passione in modo totalizzante.
Avete presente quando Lamar Jackson al termine di una corsa sgattaiola fuori dal campo per evitare un tackle e, così facendo, abbassare il rischio di rimediare un infortunio?
Ecco, Andrew Luck in situazioni del genere non si sognava nemmeno di imboccare la sideline, bramava il placcaggio, il suono secco della collisione fra armature e il pensiero di sopraffare il povero defensive back di turno grazie alla propria atipica fisicità.
Era anche la stessa persona che si è presentata in ritardo a un allenamento con il proprio quarterback coach privato – Tom House – perché mentre pedalava sulla propria bicicletta si è imbattuto in un branco di ragazzini che giocavano a calcio e, essendo cresciuto in Europa, non ha saputo resistere alla tentazione di fermarsi e prendere parte alla contesa: Andrew Luck, giusto per ribadire il concetto, era quel giocatore che aveva un podcast nel quale parlava di libri dando vita a un enorme book club nel quale chiunque era invitato.
Una delle persone più educate, sensibili, introspettive, genuine, piacevoli, colte e oggettivamente sfigatina quando indossava un caschetto e un’armatura si trasformava in un cavernicolo bramoso di sangue e violenza che non aveva alcun problema a barattare la propria salute con una mazzata gratuita che gli sarebbe valsa il rispetto dei compagni in quanto lui non era un quarterback, ma un giocatore di football americano che interpretava tale posizione.
Luck, per farla breve, era una dicotomia vivente, sia in campo che fuori.
A un certo punto, però, l’Andrew Luck umano – quello senza il numero 12 sulle petto e sulla schiena – in un tipico momento di consapevolezza e lucidità, ha deciso di dire basta: a causare quella traumatica epifania fu un infortunio al polpaccio, a primo acchito una cosuccia da niente che, nel giro di un traning camp e spiccioli, si è trasformato in un caso mediatico gigantesco.
Pazienza, terapie e ulteriore pazienza sembravano costituire il necessario per tornare in campo quanto prima e condurre gli Indianapolis Colts al Super Bowl: l’anno precedente la loro sorprendente cavalcata ai playoff – avevano iniziato la stagione con una sola vittoria nelle prime sei partite – si arrestò contro gli esplosivi Chiefs del Mahomes “rookie” al Divisional Round, mica male se si tiene presente che quella maledetta spalla gli costò tutto il 2017.
https://twitter.com/coltsmilitia_/status/1547324735855374336
Tuttavia, come sappiamo fin troppo bene, Luck non era disposto a rientrare nello stesso inferno dal quale dopo tre anni di agonia aveva appena trovato modo di uscire: capire le ragioni del suo ritiro non è affatto difficile, aveva abbondantemente oltrepassato il proprio impressionante limite della sopportazione del dolore mentale, più che fisico.
Il football americano non era assolutamente il suo unico interesse nella vita, era sì la sua più grande passione ma non l’unica ragione per la quale è stato messo al mondo: la moglie Nicole, la figlia Lucy, la famiglia, gli amici e Andrew stesso meritavano la miglior versione possibile di Andrew Luck, la sua versione libera dalla spada di Damocle del costante dolore fisico.
I soldi non erano un problema, trovare cose da fare nel tempo libero nemmeno, quindi perché perseverare nel farsi punire, torturare e straziare da quella che avrebbe dovuto essere la sua più grande passione?
Avevo bisogno di questo podcast, era indispensabile che qualcuno o qualcosa chiudesse finalmente il cerchio dandomi la risposta di cui avevo bisogno, anche se non è proprio quella in cui speravo: Andrew Luck non tornerà in campo, il capitolo football americano è ufficialmente chiuso e – questo è ciò che mi fa sentire veramente bene – lui non ha alcun tipo di rimpianto.
Certo, credo che nella sua interiorità di tanto in tanto transiti qualche pensiero su dove sarebbero potuti arrivare lui e i Colts, ma circoscrivere Andrew Luck al football americano rappresenterebbe la più grande mancanza di rispetto nei suoi confronti, anche se a lui quasi sicuramente ciò non creerebbe alcun problema.
Andrew Luck è stata la più gloriosa mosca bianca nella storia della National Football League, un individuo completamente diverso da chi lo ha preceduto – e seguito – non in funzione di caratteristiche tecniche o fisiche ma per una personalità così interessante e poliedrica da risultare quasi impossibile da descrivere se non provando ad affidarsi a liste e asindeti: Andrew Luck era la dicotomia fra i prototipi di nerd e jock, quello che dopo essere stato scaraventato al suolo violentemente si congratulava con i pass rusher avversari per il buon lavoro svolto, il ragazzo nato nel 1989 senza alcun social network e ancora con un telefono a conchiglia con cui è già tanto se puoi chiamare e mandare SMS, il fantasma che malgrado abiti a cinque minuti dal Lucas Oil Stadium di Indianapolis nessuno riesce mai a vedere… potrei andare avanti per ore.
Andrew Luck, in un certo senso, è il sogno di noi che vorremmo disperatamente campare scrivendo di football americano, perché il miglior modo per promuovere uno sport e arrivare al grande pubblico è quello di raccontare nel migliore dei modi le personalità più affascinanti e peculiari: come posso convincere un neofita ad appassionarsi dello sport nel quale una partita dura più di tre ore e il tempo effettivo di gioco non scollina nemmeno quota venti minuti?
Semplice, mettendolo davanti a soggetti come Andrew Luck, persone che non vorremmo solamente vedere condurre un attacco ma che staremmo sentire a parlare per ore.
In questo senso Andrew Luck era un talento generazionale, perché malgrado i palmares comicamente incomparabili credo che nessuno sia interessato a sentire Tom Brady parlare per ore di positività o idratazione, così come nessuno ha veramente voglia di prestare attenzioni ad Aaron Rodgers e le sue teorie alternative su più o meno qualsiasi altro argomento: ascoltare Luck articolare una risposta, analizzare le sue scelte lessicali e la sua gestualità è un esercizio tanto interessante quanto poteva esserlo guardare i suoi All-22.
My wife was at a book luncheon benefit today. Andrew Luck was the emcee.
So since Luck’s retirement, we’ve seen him in person the same amount of times:
PubblicitàOne pic.twitter.com/02FGjeWBE3
— Kevin Bowen (@KBowen1070) April 22, 2022
Era un giocatore straordinario, un quarterback terribilmente divertente da veder giocare benedetto da un talento fuori dal comune che, però, non è mai stato solamente un quarterback e che per questa ragione ha giustamente deciso di ritirarsi da una battaglia contro sé stesso e la sua testardaggine al fine di tornare a condurre un’esistenza normale scandita da libri, lunghe pedalate e attività da normale padre di famiglia.
Per la prima volta da quasi tre anni a questa parte, a sentir pronunciare il nome “Andrew Luck” non provo più quella malinconia dettata dai dubbi su cosa sarebbe potuto essere perché ho finalmente la certezza che dentro di lui non ci sia alcun rimpianto ma solo tanta serenità: era ciò di cui avevo bisogno.



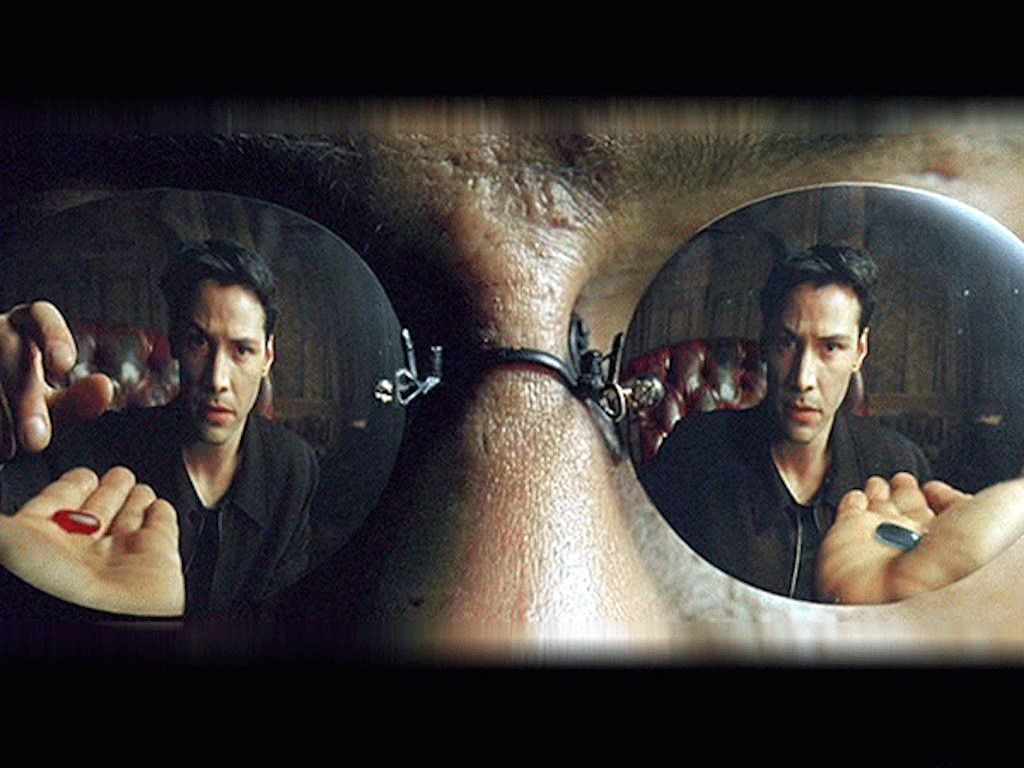




Bellissimo articolo, complimenti.